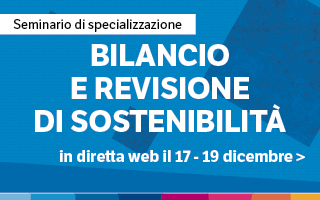Certezza e probabilità nelle perdite su crediti: “nozioni solo convenzionali”
di Luciano SorgatoNell’indagine del regime fiscale delle perdite su crediti va distinta la presunta inesigibilità del credito per prospettiche cause di insolvenza del creditore, dalla fattispecie relativa all’estinzione del titolo giuridico alla base del credito medesimo. Le 2 fattispecie all’evidenza non si accomunano sul piano dei presupposti, anche se l’Amministrazione finanziaria tendenzialmente pone alla base di entrambe l’onere della prova di un’azione di rivalsa infruttuosa per mancanza di una capiente dote patrimoniale del debitore.
L’indagine del regime fiscale delle perdite sui crediti nel reddito d’impresa
Si ritiene utile esaminare lo scrutinio del tema fiscale delle perdite fiscali in regime d’impresa a partire dalla recente risposta a interpello n. 102/E/2023, nella quale l’Agenzia delle entrate riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti ceduti con la formula della cessione – pro soluto solo in quanto il cessionario sia un intermediario soggetto a vigilanza.
Nella risposta l’Amministrazione finanziaria dopo aver testualmente passato in rassegna l’articolo 101, comma 5, Tuir, richiama la circolare n. 26/E/2013 nella parte in cui viene letteralmente precisato che l’inciso “le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi” costituisce la prescrizione legislativa di principale riferimento, dalla quale deriva che la deduzione è ammessa solo in presenza di una perdita definitiva … A tal fine la definitività si ha quando il creditore non riesce a realizzare, in tutto o in parte, il diritto di credito. Diversamente nel caso si possa ritenere che si tratti di inesigibilità solo temporanea, non sussistono i requisiti della definitività della perdita. Il presupposto della definitività si ha quando il credito viene ceduto a banche o ad altri intermediari finanziari vigilati che risultano indipendenti ai sensi dell’art 2359 cod. civ. rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto”.
Il restringimento di rilevanza fiscale della cessione dei crediti – pro soluto nei soli confronti degli intermediari vigilati, appare giustificabile più per il timore di manovre elusive, che per l’effettiva aderenza ai principi di diritto desumibili dall’articolo 101, comma 5, Tuir, alla base dei quali dev’essere tenuta distinta la perdita che deriva da atti giuridici che estinguono la fonte della titolarità del credito, dalla c.d. perdita per inesigibilità del credito. Solo in tale ultimo caso si rende rinvenibile la necessità di un giudizio probabilistico sull’irreversibilità della condizione di insolvenza del debitore.
Ma, anche in tale ultimo caso, in ordine al quale si registra la maggiore tensione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti accertati, si deve considerare come, al di là dell’assoluto rigore di vis dimostrativa ordinariamente preteso dai verificatori, il thema probandum sostanziale sia solo costituito da una valutazione probabilistica e non dalla rappresentazione dall’esistenza di una prova certa.
Nella letteratura accademica, in ordine al corretto scrutinio di “elementi certi e precisi” alla base dell’inesigibilità del credito, viene evidenziato come essi non debbano apparire portatori di una prova storica, ma di una vocazione probabilistica, atta, non a radicare “una perdita documentata”, ma piuttosto a suffragare documentalmente la prova indiziaria della sufficiente probabilità della perdita del credito.
Per la dottrina la controversia interpretativa in ordine alle perdite dei crediti deve essere incapsulata, più che in una fuorviante scelta tra certezza e probabilità della perdita, nell’individuazione di “momenti temporali”, in cui essa è sufficientemente probabile per essere tenuta in considerazione.
Le perdite dovute all’inesigibilità del credito non possono che derivare da verifiche sulle condizioni patrimoniali del debitore, sulle garanzie disponibili, etc.. Infatti, sino a quando l’esistenza del diritto di credito sussiste, qualsiasi valutazione sulla perdita economica del credito non può che essere ispirata a criteri di più o meno intensa probabilità.
Il debitore, ai sensi dell’articolo 2740, cod. civ. risponde, infatti, con tutto il suo patrimonio presente e futuro, per cui non può escludersi l’emersione di attività tali da consentire il recupero del credito. In sostanza, sino a quando la titolarità del diritto permane, non appare escludibile una sia pur minima probabilità di recupero del credito, per cui le perdite in ultima analisi si fondano su valutazioni, le quali possono apparire solo probabilistiche. Anche nell’ipotesi di procedure concorsuali, la chiusura del fallimento non esclude l’emersione, nel patrimonio del fallito, di nuove attività idonee a consentire ulteriori ripartizioni o a consentire ai creditori insoddisfatti di procedere ad azioni individuali sui beni che nel frattempo sono entrati nel compendio patrimoniale del fallito.
In dottrina[1], si ritiene che gli “elementi certi e precisi” di cui all’articolo 101, comma 5, Tuir, non possono che intendersi, anche in base ai descritti rapporti di teoria generale tra probabilità e certezza, solo in senso molto relativo, per cui, rifuggendo da schematiche e rigide contrapposizioni tra concetti (certezza e probabilità) solo quantitativamente diversi, il diritto di deduzione fiscale risulta correlarsi alla sola alta probabilità della perdita economica, in quanto non si tratta di dimostrare un evento, ma piuttosto di conferire probabilità a una valutazione.
La certezza della perdita non si contrappone alla sua probabilità, in quanto la valutazione del credito, sotto il profilo della recuperabilità, consiste nello stabilire quando la probabilità della sua perdita diventi talmente elevata, anche in connessione a una manifesta antieconomicità in ordine alle eventuali azioni intraprendibili per il suo recupero, da assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito.
La convenzionalità della contrapposizione tra probabilità e certezza in materia di giudizi storici è stata rilevata in teoria generale proprio in dottrina[2] e la linea di confine tra i 2 concetti è venuta gradualmente sfumando, dal momento che la certezza viene vista come una nozione convenzionale, abbinata a situazioni in cui la probabilità di una certa ipotesi è talmente elevata da far trascurare (cioè ragionevolmente escludere) le ipotesi contrarie. Già secondo la dottrina[3] “esaminando con sincerità scientifica la certezza e il dubbio, si constata che entrambi sono fatti di probabilità e un semplice punto correlato alla scala delle probabilità divide il dubbio dalla certezza”.
Nel caso, invece, di atti dispositivi sul credito, proprio come nel caso di cessione pro soluto del credito, indipendentemente dalla natura del cessionario, il relativo atto giuridico, estinguendo la titolarità del credito, rende certa la perdita. In tale caso, non trattasi di perdita da inesigibilità che richiede di dimostrare, in base alle nozioni di esperienza comune l’irrecuperabilità del credito, dal momento che essa deriva, con diretto nesso causale, dall’atto giuridico che ha determinato l’estinzione della fonte della titolarità del credito. Lo status soggettivo del cessionario non interagisce con la certezza della perdita sul credito, ma piuttosto con il piano delle preclusioni elusive che possono rinvenirsi alla base di cessioni solo preordinate a procurare la deduzione fiscale della perdita del credito.
Sempre in ordine allo scrutinio giuridico relativo alla deduzione fiscale delle perdite sui crediti appare anche rilevante sottolineare come l’articolo 33, comma 5, D.L. 83/2012, tra le modifiche introdotte all’articolo 101, comma 5, Tuir, abbia previsto quale fondamento causale della perdita fiscalmente rilevante la sopravvenienza della prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Com’è noto, e in estrema sintesi, la prescrizione determina l’estinzione del titolo giuridico per il semplice decorso del tempo in unione con l’inerzia da ogni azione di rivalsa del creditore. Da tale previsione normativa deriva che:
- la perdita del credito può derivare, non solo da circostanze di forza maggiore del tutto estranee al dominio d’agire del contribuente, ma anche in forza del suo volere potestativo di procurare, attraverso l’inerzia, l’estinzione del diritto di credito;
- gli elementi certi e precisi connessi alla rilevanza fiscale della perdita del credito, non dipendono necessariamente, quindi, da una manifesta condizione di insolvenza e di incapienza patrimoniale del debitore, ma anche dall’effetto legale procurato dalla prescrizione, che può anche derivare da un giudizio di opportunità commerciale a non intraprendere azioni esecutive nei confronti del debitore o da uno scrutinio valutativo sull’antieconomicità della rivalsa, in quanto è la prescrizione a costituire il presupposto legale della rilevanza fiscale della perdita del credito.
Tale fattispecie, specificamente precisata dal Legislatore, non può non essere assumibile a paradigma indicativo di un più ampio novero di situazioni con prerogative giuridiche fondate sull’unitario denominatore comune rappresentato dalla perdita del titolo giuridico alla base del credito.
In altri termini, sul piano della corretta esegesi, tale inclusione normativa nella disciplina fiscale delle perdite su crediti, non appare corretto isolarla, ma, anzi, in coordinamento con la sua ratio, costituita dall’evidente volere legislativo di assumere a chiaro peso specifico la perdita del titolo giuridico a supporto del credito, essa va ampliata a tutte le fattispecie il cui effetto legale è quello di far cessare, sul piano del diritto positivo, l’esistenza del titolo giuridico alla base del credito, tra cui, ad esempio, è annoverabile la rinuncia al credito sempre per motivi di convenienza commerciale o di antieconomicità della rivalsa.
L’indicata modifica normativa ha solo rappresentato l’avvallo legislativo di quanto sostenuto in dottrina e cioè che l’estinzione del titolo giuridico alla base del credito, determina la condizione irreversibile della sua perdita, e la mera connessione causale con ragioni di opportunità commerciali o di antieconomicità (già rilevabili sulla base di induzioni logiche e, quindi, senza alcuna necessità di rigore probatorio in ordine alla condizione di insolvenza del creditore) bastano per il pieno recupero dei presupposti che consentono di dedurre fiscalmente la perdita.
Nella risposta a interpello n. 102/E/2023 l’Agenzia delle entrate limita la rilevanza fiscale della perdita alla sola cessione pro soluto dei crediti a banche e intermediari finanziari, trascurando di considerare che l’elemento fondativo della rilevanza fiscale della perdita non è il destinatario della cessione, ma l’effetto estintivo del titolo giuridico alla base del credito. Sottesa alla precisazione che destinatari possono essere solo “banche e intermediari finanziari”, non vi è una coerente indagine sui presupposti fiscali delle perdite sui crediti, ma la pretesa di un rigore di prova che il Legislatore ha invece smentito proprio con l’aggiunta della previsione legislativa della prescrizione, la quale e senza alcun ulteriore onere di prova è nella condizione legislativa di consentire la deduzione fiscale della perdita del credito estinto.
La prescrizione, si ripete, si fonda sulla mera inerzia del contribuente verso il proprio diritto, su un modello di comportamento passivo e non su dinamiche attive di rivalsa, mentre l’Agenzia delle entrate, invece di ritrarre i corretti impulsi esegetici dalla rappresentata aggiunta legislativa, tende a fermarsi alla sola evidenza inconfutabile della procedura concorsuale, dal momento che, in sede di verifica, anche l’azione esecutiva individuale viene spesso ritenuta solo parziale e inidonea a provare la mancanza di patrimonio capiente (anche se talora, ma con alternanza di giudizi, smentita dal giudice di vertice: Cassazione, sentenze n. 23863/2007 e n. 17087/2009, con le quali il supremo giudice ha sostenuto che la previsione legislativa di elementi certi e precisi, che testualmente vengono connotati come “probatori”, obbliga a ritenere che non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite contestate risultino documentate in modo certo e preciso, per cui, in diritto, va esclusa la necessità dell’accertamento dell’insolvenza del debitore tra gli elementi costitutivi del diritto del contribuente alla deduzione).
In ordine alla falsa applicazione del canone dell’antieconomicità nel giudizio dei fatti d’impresa
In ordine al parametro valutativo dell’antieconomicità dei fatti d’impresa, così si esprime e con senso giuridico che non può non essere condiviso: “In molte circostanze motivi di opportunità commerciale, di immagine, di correlazione soggettiva con gli utenti dei servizi venduti, possono indurre l’operatore economico a non esercitare un diritto che formalmente potrebbe esercitare, per cui ai fini della determinazione giuridico-amministrativa della capacità contributiva i diritti astrattamente nascenti dal codice civile non rappresentano una capacità contributiva effettiva e la pretesa di correlarli inferenzialmente con redditi evasi corrisponde solo ad una lettura estremamente formalistica del fenomeno economico”[4].
La mancata teorizzazione dell’oggetto economico nel diritto tributario, porta l’Amministrazione finanziaria a individuare il baricentro concettuale del medesimo nel modello di normalità economica. Modello, però, solo esteriormente paradigmatico, in quanto esso si rivela del tutto inadatto a scrutinare con il criterio dell’effettività l’attitudine economica del singolo contribuente.
In altri termini, le convenienze commerciali o i diritti astrattamente azionabili da un contratto stipulato dal contribuente non costituiscono una capacità economica effettiva, per cui i maggiori ricavi o i minori costi che eventualmente l’impresa avrebbe potuto conseguire o sostenere, ma che in concreto non ha conseguito e/o sostenuto in detta misura, non possono formare oggetto di recupero, in quanto, diversamente, si verrebbero a sostituire con regole empiriche le basi giuridiche e costituzionali su cui poggia la base imponibile fiscalmente rilevante. Il concetto di congruità, quale asserito profilo dell’inerenza, farebbe in modo che il valore medio-normale venga ad assumere l’assetto di presupposto sostanziale in un processo di “normalizzazione atecnica del reddito”: da strumento di natura surrogatoria delle transazioni commerciali in natura, in strumento che riverbera effetti stabili direttamente sulla determinazione della base imponibile, avvallando così una metodologia di tassazione che, anziché, colpire una ricchezza effettiva e misurata secondo canoni di stima oggettivi, ha a oggetto una capacità contributiva astratta e di massa.
In un sistema incentrato sul principio della riserva di legge, è universalmente riconosciuto che il contribuente può regolare i propri affari sulla base di opzioni meno impegnative sul fronte fiscale[5], nel senso che può agire secondo liberi schemi d’azione ai quali l’obbligazione tributaria deve conformarsi. Non è l’obbligo impositivo a poter condizionare la pianificazione d’impresa. Il difetto di precettività delle norme tributarie obbliga a conformare le conseguenze impositive alla sola forza economica dei fatti imputabili al contribuente, senza poterla connettere a canoni standardizzati, a medie solo rappresentative di grandezze convenzionali
Per la citata dottrina[6]: “Il contribuente che si dissocia dal canone identificante la normalità è (in base alla tesi sostenuta dall’Ufficio) un “deviante”, un “cane sciolto”, uno che “canta fuori dal coro” e che in qualche modo deve essere ricondotto nei binari predefiniti del “ciò che ci si aspetta da lui””. Non può, quindi, non apparire anormale un’azione impositiva incentrata sul pseudo faro della normalità, ritenendo “falsi” i valori impositivi non omogenei con tale canone.
La prova del fondamento giuridico di tali argomenti deriva proprio dalle presunzioni di reddito che scaturiscono dalla speciale disciplina fiscale delle società di comodo. Se la verifica potesse liberamente raccordare l’obbligazione tributaria a modelli strategici, organizzativi e operativi rispondenti al virtuale canone della normalità, allora non vi sarebbe l’esigenza di sostenere con specifiche previsioni normative una potestà impositiva graduata su calcoli matematici, idealmente rappresentativi del modello della normalità, in alcuni ben circostanziati casi. Queste norme e correlati schemi presuntivi legali, sono invece indicativi del fatto che tali inferenze convenzionali sono lecite solo in casi eccezionali e tassativamente individuati dal Legislatore e non la spia casistica di un principio da assumere a regime.
Un conto è l’inesistenza o la simulazione del componente di reddito, altro è un costo realmente sostenuto, anche se non rispondente ai paradigmi del normale profitto. In tale ultimo caso si tassa solo una capacità contributiva inesistente e si connette la natura dell’obbligazione tributaria a quella di una prestazione confiscatoria e non di solidale partecipazione alla finanza sociale.
Anche il presupposto dell’inerenza non può più sussidiare l’antieconomicità, in quanto si tratterebbe di tornare ad arretrare l’inerenza alla sua versione storica di 150 anni fa (articolo 32 del primo Testo unico delle leggi tributarie in Italia n. 4021 del 24 agosto 1887, nel quale era dato testualmente rinvenire “per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione”, inteso come raccordo estremamente ristrettivo che consentiva di dedurre dalla ricchezza lorda prodotta solo i componenti negativi che costituivano la reintegrazione delle forze economiche consumate dall’imprenditore, sino a incorporarsi in maniera quasi fisica al prodotto[7]. Tale visione causale può dirsi ora del tutto archiviata a favore di uno scrutinio che si traduce in una verifica di causalità solo qualitativa con le generali dinamiche imprenditoriali, senza la possibilità di accertare la congruità della spesa, a meno che non sia rinvenibile una macroscopica sproporzione tra l’ammontare del costo e l’effetto da esso generato sullo svolgimento generale dell’attività d’impresa.
Relativamente al principio dell’inerenza si deve considerare come la Cassazione abbia ora preso atto come il Legislatore, con le Riforme fiscali del 1971 e del 1986, abbia individuato il fondamento causale del diritto di deduzione fiscale del costo al suo solo ricongiungimento qualitativo con l’attività d’impresa, escludendo il condizionamento del parametro utilitaristico – quantitativo. Assumono rilievo le condizioni specifiche di mercato in cui opera l’imprenditore, le quali forniscono gli strumenti utili per valutare se una data spesa prospetti o meno un raccordo causale con le dinamiche imprenditoriali[8]. Sono solo le dinamiche operative a coordinare il primato valutativo sull’inerenza di un costo da intendere non come rigoroso nesso di causa – effetto con i ricavi, ma come raccordo causale con i bisogni e le convenienze dell’impresa, senza la predeterminazione di necessari imponibili fiscali. Anche, come sostiene Lupi, solo motivi di opportunità commerciale, di immagine, di correlazione soggettiva con gli utenti dei servizi e beni venduti, possono indurre l’operatore economico a non esercitare un diritto che magari formalmente potrebbe venire azionato in quanto supportato da diritti astrattamente nascenti dal codice civile. Ma trattasi di schemi di rivalsa che partecipano della sua libera azione d’impresa e che, in assenza di condotte simulatorie, vanno intesi come insindacabili dall’Amministrazione finanziaria.
Il rischio della doppia imposizione fiscale
Il tema delle perdite su crediti coinvolge anche il principio costituzionalmente orientate del divieto della doppia tassazione che l’articolo 163, Tuir preclude anche nei confronti di soggetti diversi, partecipando esso delle inderogabili prerogative dell’obbligazione tributaria come esse congiuntamente derivano dall’unione degli articoli 41 e 53, Costituzione che non ammettono alcuna imposta di tipo confiscatorio.
Per la dottrina che più si è occupata dello specifico tema[9] il “divieto della doppia imposizione”, più che ricavarsi dalla espressa disposizione normativa (articolo 8, comma 3, lettera b), R.D. 4021/1877, articolo 7, D.P.R. 645/1958 e articolo 67, D.P.R. 600/1973 conclusivamente trasfuso nell’articolo 163, Tuir) costituisce esso principio immanente al sistema tributario. Esso assolve ad almeno 2 funzioni:
- da un lato, nell’ambito dell’interpretazione delle norme tributarie ove coordina l’opera ermeneutica, obbligando a ripudiare ogni coordinamento esegetico che intenti di giustificare una qualsiasi manifestazione di doppia imposizione (indipendentemente dal suo paradigma giuridico o economico);
- dall’altro nell’ambito dell’imposizione sostanziale, quale custode di un obbligo impositivo che non alteri il costituzionale bilanciamento tra ricchezza privata e risorsa pubblica.
Per chiara dottrina[10] il divieto della doppia imposizione non si contrassegna alla stregua di un principio generale dei vari tipi di reddito, ma come fondamentale “norma di orientamento costituzionale”, mai raggirabile nella conformazione strutturale dell’obbligazione tributaria. In altri termini trattasi di principio che partecipa con nesso diretto dei fondamenti costituzionali dell’obbligazione tributaria e la sua violazione genera distorsioni proprio nella struttura costituzionale del diritto fiscale.
Non trattasi di un generico principio tributario che si raccorda con la fase di attuazione del tributo, ma di un principio che concorre in modo diretto alla struttura costituzionalmente indisponibile dell’obbligazione tributaria, per cui la trasgressione della portata di tale principio rende l’obbligo impositivo declinato in modo non coerente con i presidi di rango costituzionale. In altri termini lo rende contra Costituzione.
Per la citata dottrina accademica il privilegio gerarchico di tale principio in questione deriva dalla necessità che la ricchezza insita in un qualsiasi fatto economico non abbia da commutarsi in modo confiscatorio in risorsa pubblica, interdicendo all’economia privata che l’ha generata il mantenimento di quella parte di essa che le consente di reiterare e rafforzare l’iniziativa individuale. Il doppio prelievo sia nei confronti del medesimo soggetto sia nei confronti di soggetti diversi trasforma la ricchezza privata in una confiscatoria ricchezza pubblica, in trasgressione dell’articolo 41, Costituzione che invece presidia e tutela l’iniziativa privata.
È di fondamentale importanza il perseguimento del necessario bilanciamento della diversità degli interessi pubblici e privati che si intersecano nella conformazione della c.d. “giusta obbligazione tributaria” in maniera da declinarla in modo strutturalmente coerente con i complessivi principi costituzionali che la presidiano.
Proprio per la necessaria osservanza di tale principio, si rende imprescindibile valutare gli effetti della ripresa fiscale di una perdita di un credito congiunto a un autentico fatto d’impresa (e, quindi, non confondibile con un atto di godimento personale dell’imprenditore), dal momento che essa genera la sopravvenienza attiva tassabile in regime d’impresa nei confronti dell’imprenditore debitore. Se a fronte di tale sopravvenienza attiva si ricongiungesse anche la ripresa fiscale della perdita, nel caso che ab origine si tratti di autentico atto commerciale, viene a generarsi proprio la doppia tassazione che l’articolo 163, Tuir vieta a presidio dei principi costituzionali sopra rappresentati. Anche per tale fondamentale ragione il giudizio sull’inerenza della perdita del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria andrebbe limitato alla verifica di circoscritti fondamenti causali, quali la mera liberalità, la simulazione dell’atto di godimento personale, l’assoluta totale estraneità della rinuncia o della prescrizione del credito da ogni logica d’impresa, senza la pretesa di correlare il giudizio sull’inerenza dell’estinzione del titolo giuridico sotteso al credito, alla mancanza di autentiche sinergie con le dinamiche imprenditoriali di mercato, valutate in unione con le rigorose regole di logica operativa ispirate al massimo profitto.
Aspetti pratico-operativi
In molte circostanze nei pvc è dato testualmente rinvenire: “in assenza di procedure concorsuali ciò a cui bisogna tendere è la probabilità di poter recuperare il credito in tutto o in parte. Infatti non si può parlare di certezza assoluta sino a quando esiste una se pur piccola probabilità di recuperare il credito”. Per gli estensori di tale passo, quindi, anche di fronte a una insignificante probabilità di recuperare il credito, si deve continuare a sostenere ingenti e antieconomiche spese di recupero del medesimo, allo scopo di pervenire a una condizione di (inesistente) certezza assoluta in ordine alla inesigibilità del credito. L’asserzione sopra riportata o frasi simili molte volte presenti negli avvisi di accertamento trascurano persino quanto rappresentato nella circolare n. 26/E/2013 per la quale testualmente: “Un elemento di prova sicuramente utile può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive. Al riguardo, possono essere tenute in considerazioni le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (cfr. Cassazione, sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001)”.
Insigni giuristi sono concordi nel raccordare il giudizio valutativo del probabilismo a un concetto di certezza meramente convenzionale e negli avvisi di accertamento è dato talora testualmente rinvenire: “L’Amministrazione finanziaria ha sempre valutato gli elementi di certezza e precisione richiesti dalla norma in modo rigoroso e restrittivo, escludendo ogni elemento presuntivo, poiché se la valutazione delle perdite potesse avvenire su base estimativa e presuntiva, verrebbe attribuita al contribuente una discrezionalità che la legge non consente”.
Escludere, come ritiene di fare l’estensore erariale della frase sopra riportata, da uno scrutinio necessariamente valutativo, il valore dimostrativo delle presunzioni secondo il loro paradigma di inferenze logiche tra fatti noti e fatti indotti, sul piano del diritto significa solo confondere la diversità dei presupposti alla base dell’accertamento di un fatto materiale di gestione (la cessione di un bene, la liquidazione di un salario) rispetto alla probabilità di manifestazione di un evento[11].
In molte occasioni negli avvisi di accertamento a supporto dell’indeducibilità delle perdite su crediti si rinvengono solo frasi di mero stile, unicamente volte a fare in qualche modo ostruzione al lecito diritto di deduzione fiscale delle medesime, del tutto antitetiche agli scrutini giuridici proposti dalla dottrina sopra rappresentata e che ben possono costituire nei ricorsi autentici baluardi di diritto alla cortina fumogena sollevata dall’Amministrazione finanziaria.
Conclusioni
Il tema fiscale delle perdite su crediti costituisce l’emblema del malessere della legislazione fiscale in Italia, dal momento che ogni volta che il dato legislativo richiede una qualche componente valutativa soggettiva, essa viene sempre intesa dall’Agenzia delle entrate nel senso più ristrettivo possibile, sino ad annullarne la ratio (proprio come appare esser la risposta a interpello qui commentata). Un conto è avversare comportamenti realmente pregiudizievoli dei diritti erariali dei contribuenti ed altro è ingerirsi nella portata del dato di legge sino a renderlo tam quam non esset
Non possono non venire a mente le parole del prof. Lupi[12] per il quale testualmente: “La ricchezza non registrata” (l’unica vera ricchezza che presta autentica antitesi ai canoni costituzionali della capacità contributiva in quanto sinonima della vera evasione), qualora durante la verifica non venga rinvenuti nulla di anomalo, di evaso, non essendosi riscontrate evidenze di sorta in ordine all’occultamento di ricavi, allora i rilievi vengono concentrati sul regime giuridico della ricchezza palese, quella registrata, agevolmente scrutinabile, con canoni esegetici (“litanie interpretative” per Lupi) solo idonei a generare basi imponibili esistenti unicamente nell’ immaginario, che nessuno ha mai prodotto, ma che rischiano, non di debellare il pregiudizio sociale dell’evasione, ma la base produttiva del Paese.
In fondo (sempre testualmente per il Lupi) le contestazioni di diritto (soprattutto se trattasi del diritto tributario italiano) possono sempre essere fondate su astratti e immancabili materiali normativi, cortine fumogene che magari un qualche fondamento riescono anche ad averlo, e su litanie interpretative che, proprio perché connesse a scenari giuridici martoriati da frequentissimi scoordinamenti legislativi, sentenze improvvisate e pubblicistica di ogni livello, riescono a trovare, in un qualche modo, un qualche supporto e la prospettiva di un successo giudiziario, che proprio a causa di un diritto tributario di tale genere, si presta a essere sempre ipotizzabile.
Tuttavia, non si deve omettere di considerare che l’autentica vocazione del diritto non è mai ispirata a ragioni di servizio, ma solo a presidiare il giusto dovere contributivo.
[1] R. Lupi, “Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti”, in Rassegna tributaria n. 5/1987.
[2] P. Calamandrei, “Verità e verosimiglianza nel processo civile” in Studi sul processo civile, Padova, 1957.
[3] P. Seraceno, “Le decisioni sul fatto incerto nel processo penale” Padova, 1940.
[4] R. Lupi, “Evasione fiscale, paradiso e inferno”, Milano, 2008.
[5] Si veda in tal senso M. Beghin, “Agevolazioni, Componenti reddituali fuori mercato ed evasione fiscale”, in Corriere tributario n. 3/2009.
[6] M. Beghin, “Le prestazioni di servizi gratuite e la presunzione semplice di evasione fiscale tra “normalità economica” e “contribuenti replicanti”, in Rivista di diritto tributario n. 4/2008.
[7] O. Quarta, “Commento alla legge sulla imposta di ricchezza mobile”, volume II, Milano, 1920.
[8] Cassazione n. 450/2018, n. 3170/2018, n. 12738/2018, n. 18904/2018 e n. 28692/2019.
[9] M. C. Fregni, “Appunti in tema di doppia imposizione” in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1993, N. Lanteri, “L’atto di accertamento e il divieto di doppia imposizione” in Diritto e pratica tributaria, 1985, E. Marello, “Il divieto di doppia imposizione come principio generale del sistema tributario” in Giurisprudenza costituzionale, 1997.
[10] G. Falsitta, “Istituzioni di diritto tributario – Parte generale”, Padova.
[11] Si rinvia a R. Lupi, “Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti” op. cit..
[12] “Parlare senza dire nulla” in Dialoghi tributari n. 3/2012.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il reddito di impresa”.