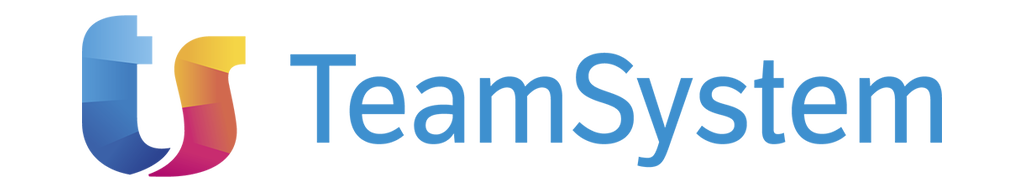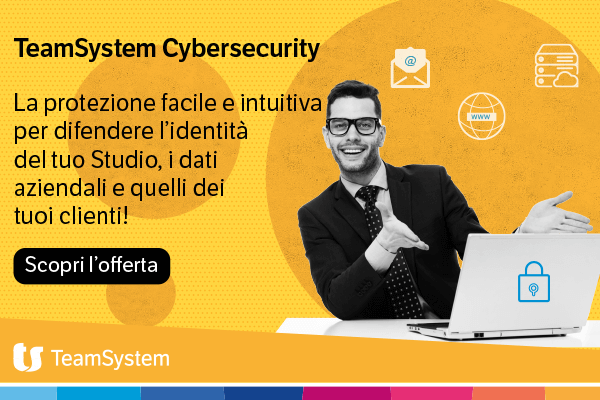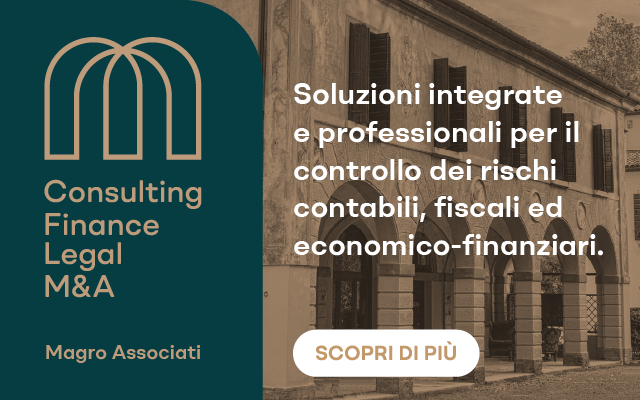- non si prescinde completamente dalla contabilità;
- vengono individuate singole attività non dichiarate o singoli costi fittizi, non globalmente il reddito d’impresa;
- la prova dell’esistenza di attività non dichiarate o dell’inesistenza di passività dichiarate è fornita dall’Ufficio con il ricorso a presunzione che devono possedere i requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Tuttavia, proprio in considerazione del fatto che la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo non richiede la dimostrazione della completa inattendibilità delle scritture contabili, la Cassazione ha chiarito che per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti, non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli, anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento. E neppure si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cassazione sentenze n. 6849/2009; n. 13319/2011; n. 3197/2013).
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha, inoltre, nuovamente ribadito che nell’accertamento dei ricavi non contabilizzati basato sulle percentuali di ricarico è illegittimo l’utilizzo del criterio della media aritmetica semplice, fondato sul mero raffronto tra i prezzi di vendita ed i prezzi dei listini delle case fornitrici, in quanto effettuato senza tenere conto alcuno della disomogeneità degli articoli venduti, che richiede un’analisi quantitativa secondo il criterio della media ponderata, in relazione al volume delle vendite relative all’uno o all’altro tipo prodotto ed ai dati relativi al mercato nel quale il contribuente si trova ad operare.
Non è, quindi, legittima la presunzione di ricavi maggiori di quelli denunciati fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli, anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento. E neppure si rende legittimo il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, anziché a quello della media ponderata, quando fra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi di prodotti più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che nel caso in cui l’accertamento sia riferito ad un’impresa che vende diverse categorie di beni e la cui attività è caratterizzata da andamenti variabili dei prezzi nel corso del tempo (es. differenza fra alta stagione, stagione ordinaria e periodo dei c.d. saldi) l’utilizzo della media aritmetica semplice nel calcolo della percentuale di ricarico è inidoneo a costituire una presunzione dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, essendo necessario fare riferimento al criterio della media ponderata, che deve essere stabilita tenendo conto della diversa quantità dei prodotti oggetto di vendita, cui si applicano diverse percentuali di ricarico. Si deve, quindi, procedere ad inserire i beni oggetto di vendita in diverse categorie omogenee, perché aventi la stessa percentuale di ricarico, ovvero a determinare una unica percentuale di ricarico, calcolata però tenendo conto del diverso “peso” dei singoli beni, cui si applicano le diverse percentuali di ricarico.