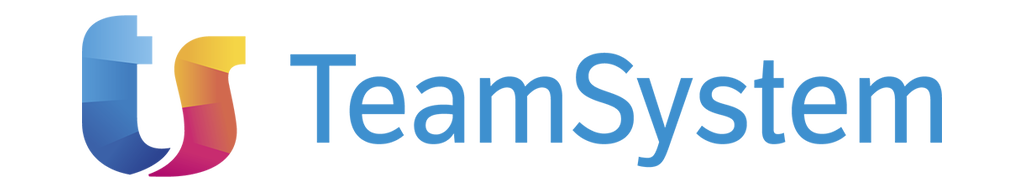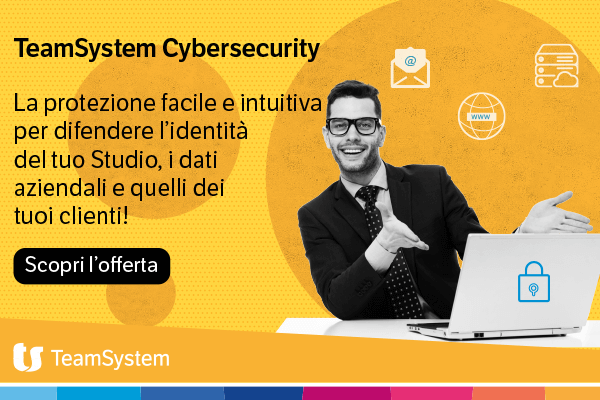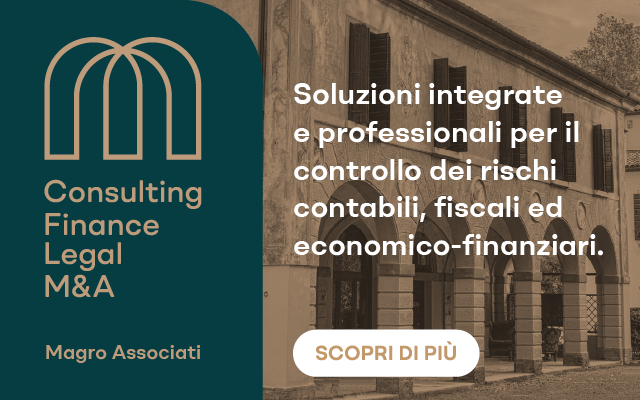Qualora il concedente sia una società di persone, il divieto di concorrenza opera anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili: riguardando esclusivamente il caso di “nuova attività”, non può, tuttavia, esplicare i propri effetti qualora il concedente prosegua l’esercizio di un’impresa preesistente all’affitto del ramo d’azienda, oppure quando l’azienda affittata non sia ancora stata esercitata, purchè ciò non si traduca di fatto in un’elusione del divieto (Cass. 30 marzo 1984, n. 2112).
Analogamente, per i contratti opera la medesima disciplina stabilita per la cessione d’azienda, contenuta nell’art. 2558 c.c.: i rapporti giuridici – ad eccezione di quelli aventi carattere personale (appalto, mandato o prestazione d’opera intellettuale, ma non agenzia, soggetto, quindi, al subentro automatico, salva la deroga contrattuale), e di quelli espressamente esclusi dalle parti – si trasferiscono, quindi, all’affittuario, senza richiedere il consenso del terzo contraente. Costui può, tuttavia, recedere dal contratto, entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, come, ad esempio, la carente affidabilità morale o patrimoniale del cessionario: al ricorrere di tale ipotesi, il concedente è responsabile, nei confronti del terzo contraente, per l’eventuale risarcimento del danno.
Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà delle parti di escludere, mediante propria ed espressa manifestazione di volontà, la successione dell’affittuario in alcuni specifici contratti. Al termine dell’affitto, tornano al concedente i contratti da lui stipulati originariamente, ed ancora in vigore, nonché quelli sottoscritti dall’affittuario, purchè siano ancora vigenti, e non abbiano carattere personale.
Non operano, invece, le disposizioni in materia di crediti e debiti dell’azienda ceduta, in quanto gli artt. 2559 e 2560 c.c. non richiamano espressamente l’ipotesi del contratto di affitto, a differenza delle precedenti norme in materia di divieto di concorrenza e successione nei contratti (artt. 2557 e 2558 c.c.). In particolare, l’art. 2559 c.c. cita esclusivamente l’usufrutto, e non anche l’affitto d’azienda: non è, quindi, invocabile il subentro dell’affittuario nei crediti del concedente in mancanza di notifica al debitore ceduto, od accettazione da parte di costui. In altri termini, nel contratto d’affitto d’azienda è possibile pattuire la cessione dei crediti, ma rimane ferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., con la conseguenza che la cessione diviene opponibile ai terzi per effetto della notifica o dell’accettazione (art. 1265 c.c.). Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, l’eventuale perdita su crediti che l’affittuario dovesse conseguire è deducibile dal reddito d’impresa (R.M. n. 424/E/2008).
Per quanto concerne, invece, i debiti, non è applicabile l’art. 2560 c.c. – secondo cui, in caso di cessione d’azienda, l’alienante non è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta, salvo che i creditori vi abbiano consentito – in quanto non è previsto alcun rinvio normativo all’affitto d’azienda: l’affittuario non assume, pertanto, alcuna responsabilità nei confronti dei creditori del concedente, così come quest’ultimo non risponde dei debiti contratti dall’affittuario durante la vigenza del contratto. Il contratto d’affitto d’azienda può comunque prevedere il trasferimento all’affittuario dei debiti del concedente, il quale non è, però, libero se il creditore non fornisce il proprio consenso (art. 1273 c.c.).