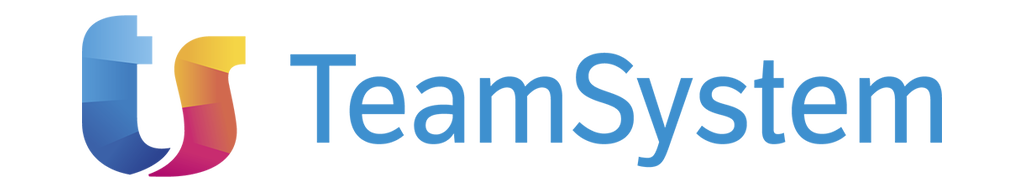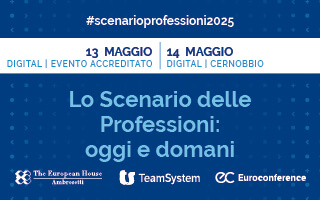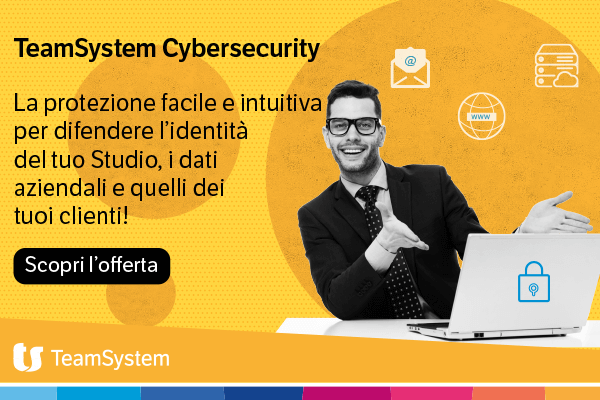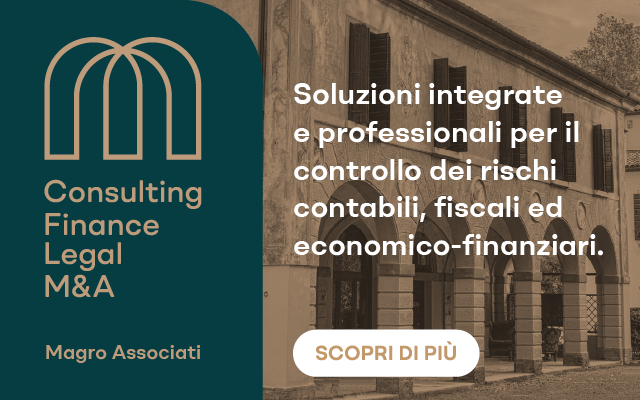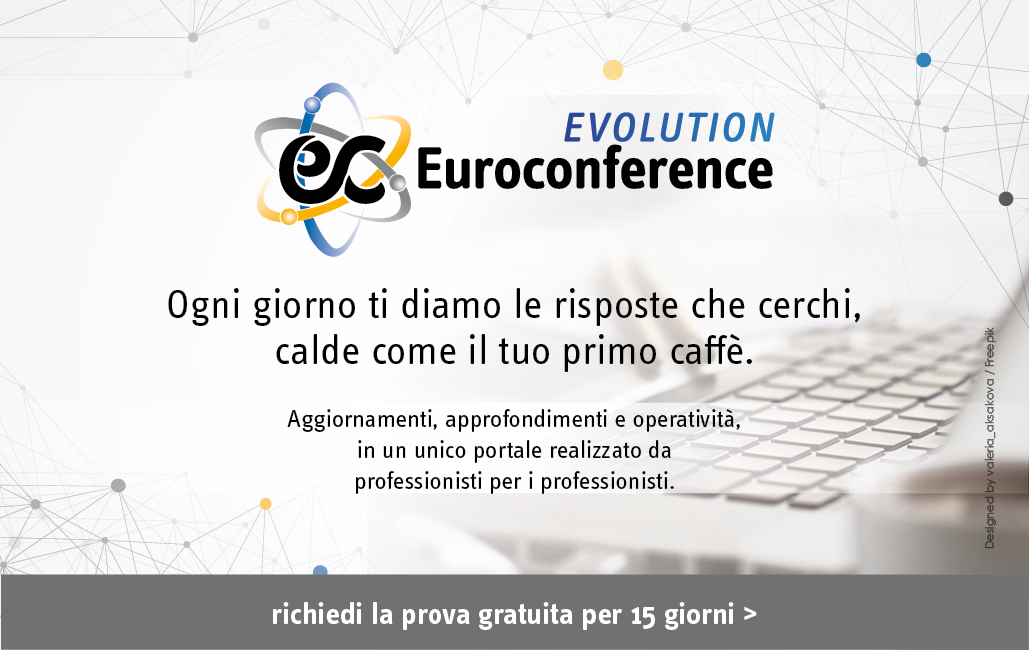Fin da subito viene pertanto anticipato un concetto già presente nella vecchia versione del principio contabile, ossia l’impossibilità di capitalizzare tra le immobilizzazioni immateriali l’avviamento generato internamente.
Oltre a ciò, il nuovo paragrafo 55 dettaglia le condizioni per l’iscrizione dell’avviamento tra le immobilizzazioni immateriali, segnatamente:
- l’acquisizione a titolo oneroso (compresi i casi di conferimento, fusione o scissione);
- la presenza di un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- l’incorporazione di oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici futuri;
- il rispetto del principio della recuperabilità del relativo costo.
Le novità assumono invece rilievo, come da più parti evidenziato, con specifico riferimento al trattamento contabile e al conseguente processo di ammortamento. La norma di riferimento è il comma 6 dell’articolo 2426 cod. civ. secondo cui “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”.
Rispetto al passato, si osserva un cambiamento sicuramente sul piano concettuale, in quanto il criterio guida per la ripartizione nel tempo di tale componente diventa la vita utile e non più l’arco temporale di 5 anni.
Sotto questo profilo, l’OIC 24 fornisce alcuni riferimenti di massima da utilizzare ai fini della stima della vita utile, quali:
- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria;
- il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato (c.d. payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale.
La durata “standard” entra poi in gioco in via residuale in tutti i casi (eccezionali) in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile dell’avviamento, che a quel punto può quindi essere ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Diversamente, le vecchie versioni del comma 6 dell’articolo 2426 e dell’OIC 24 consentivano l’ammortamento sistematico in un periodo superiore a cinque anni solo al ricorrere di specifiche ragioni – da illustrare espressamente nella nota integrativa – ricollegabili direttamente alla realtà e alla tipologia dell’impresa cui l’avviamento si riferiva; circostanze che da oggi molto probabilmente entreranno in gioco per giustificare le ragioni che possono determinare una stima della vita utile dell’avviamento superiore a dieci anni.
Sulla durata massima non si ravvisano novità in quanto la vita utile dell’avviamento (in precedenza il periodo massimo entro cui effettuare l’ammortamento) non può superare i 20 anni.
Quanto, infine, alla quantificazione del valore, il nuovo OIC 24 non contiene innovazioni: come in passato, il valore dell’avviamento va determinato per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda o ramo d’azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.