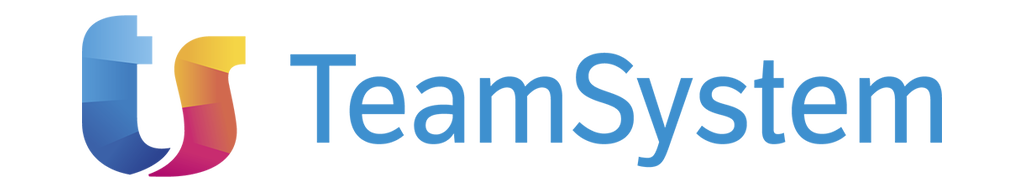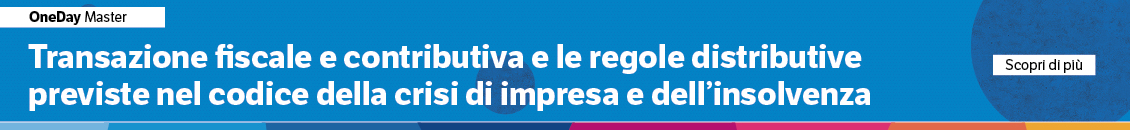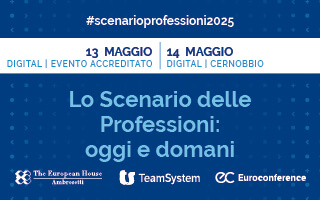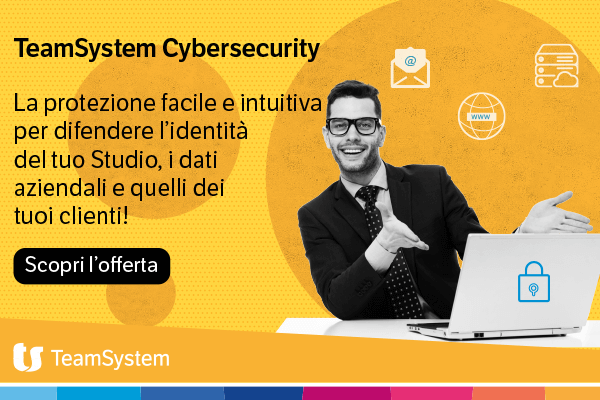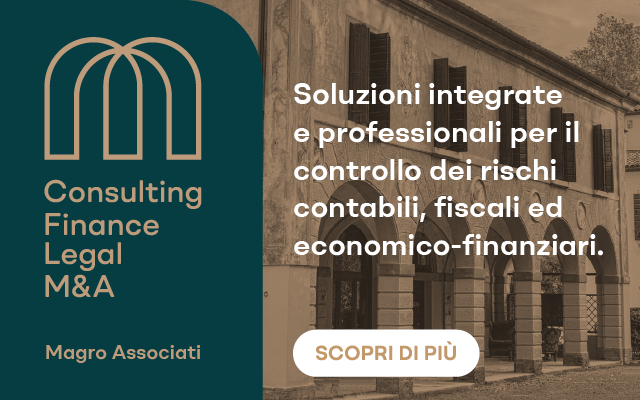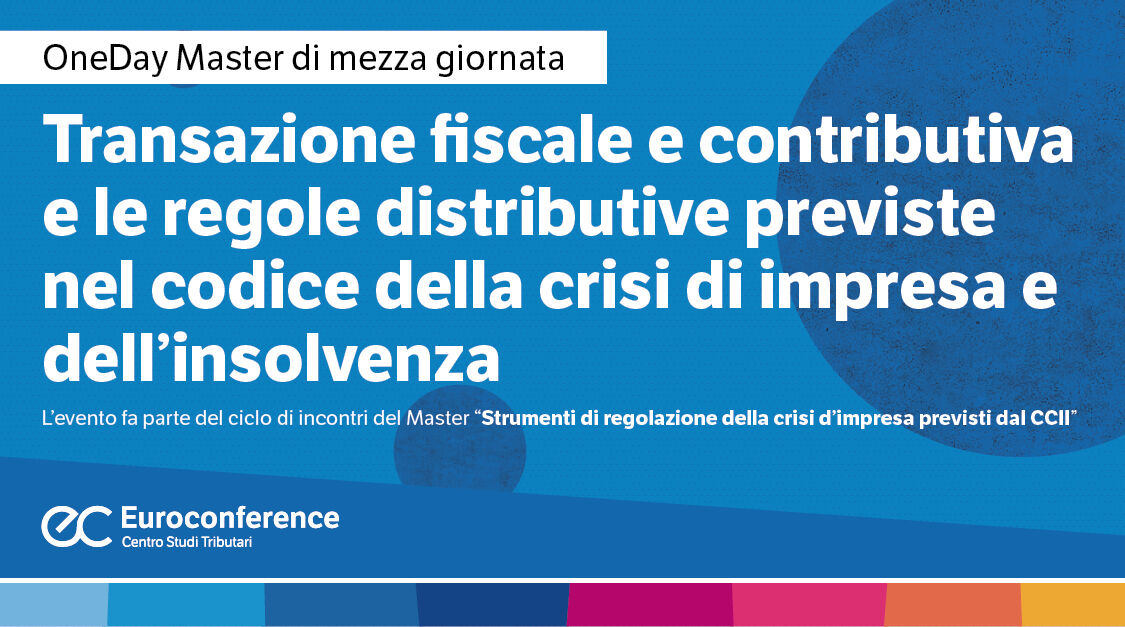- beni che già appartengono al patrimonio del debitore, ed in tal caso si verifica lo spossessamento, che rappresenta l’effetto tipico del fallimento nei confronti del debitore;
- beni che non più appartengono al patrimonio del debitore, ovverosia beni già oggetto di un atto traslativo inefficace o nullo che a seguito dell’attività recuperatoria, normalmente di natura giudiziale, vengono acquisiti al patrimonio del debitore.
In entrambi i casi, tuttavia, la conseguenza della derelictio era, ed è, una sola: il bene, nella sostanza, rientra nella disponibilità dei creditori, i quali potevano agire esecutivamente sugli stessi.
Pur mantenendo invariata nella sostanza la previgente normativa dell’articolo 104-ter, comma 8, la nuova disciplina del Codice introduce alcune significative rettifiche, in quanto la Legge Fallimentare si limitava a stabilire che la liquidazione potesse essere non avviata o, se avviata, rinunciata, in caso di manifesta non convenienza, nulla veniva disposto, però, sulle modalità della rinuncia e sulle modalità di attuazione della medesima relativamente al bene, nonché sulla valutazione della manifesta non convenienza.
L’articolo 213, comma 2, Codice, ha colmato le lacune dell’articolo 104-ter, comma 8, L.F., sotto due importanti profili:
- le modalità di esecuzione dell’autorizzazione alla rinuncia;
- la determinazione della manifesta non fondatezza.
Riguardo al primo punto, l’articolo 213, comma 2, Codice, ha stabilito espressamente che, una volta ottenuta la rinuncia, il curatore ha l’obbligo, oltre che di darne la comunicazione ai creditori, di notificare l’istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri.
È da ritenere che la comunicazione debba essere rivolta anche al fallito (ed in caso di società ai suoi soci), in quanto preliminarmente il fallito, per poterne disporre, deve anche conoscere che quei beni sono stati esclusi dalla liquidazione della procedura, ed in secondo luogo per poter esercitare i diritti e gli obblighi di controllo sul bene che gli competono quale titolare, riferiti essenzialmente al dovere di custodia e a tutti gli ulteriori obblighi conservativi che questo determina, oltre agli obblighi di carattere fiscale gravanti sul bene.
In ordine alla convenienza, l’articolo 213, comma 2, Codice, ha stabilito che si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell’attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l’aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.
La norma non pone alcun obbligo del curatore di compiere almeno sei tentativi di vendita: se il bene, per sua natura, è di difficile esitazione, il curatore, ovviamente sulla scorta di elementi ragionevoli, può chiedere al comitato dei creditori, di poter abbandonare la liquidazione, in quanto tali tentativi di vendita rappresenterebbero un aggravamento delle spese della procedura a danno dei creditori.
In secondo luogo, la norma si limita a porre una presunzione semplice, in quanto tale superabile dalla prova contraria che lo stesso curatore può invocare se deduce motivi che giustifichino ulteriori tentativi di liquidazione.
Si deve ritenere, inoltre, che la legittimazione a proporre l’istanza di procedere ai tentativi di liquidazione oltre il sesto, e quindi a vincere la presunzione di manifesta non convenienza, non spetti esclusivamente al curatore, ma anche a tutti i creditori e allo stesso fallito, che ben possono dedurre al giudice delegato, mediante apposito reclamo contro gli atti amministrativi del curatore, la sussistenza di quei giustificati motivi che legittimano la continuazione dell’attività liquidatoria.
Nel caso di procedure concorsuali radicate in data anteriore al 15.7.2022, il comma 2 dell’articolo 118, L.F., prevede che nel caso di chiusura di cui al comma 1, n. 3 e 4 (ovverosia compiuta ripartizione dell’attivo o incapienza della procedura medesima), il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro Imprese.
Ugualmente nel codice della crisi di impresa, l’articolo 233, comma 2, Codice, prevede la cancellazione dal Registro Imprese.
Pertanto, il curatore dovrà, ex articoli 213, comma 2, e 142, comma 3, Codice:
- previa autorizzazione del comitato dei creditori, rinunciare ad acquisire beni del debitore, o che pervengono al medesimo nel corso della procedura, qualora i costi da sostenere per la loro acquisizione e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei medesimi;
- depositare istanza di rinuncia alla liquidazione dei beni al giudice delegato corredata dall’autorizzazione del comitato dei creditori;
- notificare l’istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri;
- darne comunicazione ai creditori sociali i quali in deroga all’articolo 150, Codice, possono iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore con la precisazione che a seguito della chiusura della procedura concorsuale il curatore chiederà la cancellazione dal registro delle imprese. Si ritiene pertanto opportuno, qualora i creditori intendano agire di non attendere la cancellazione della società dal registro delle imprese;
- darne comunicazione anche al debitore ed in caso di società ai soci della medesima.
Nell’istanza in cui il curatore richiede la chiusura della procedura il medesimo, qualora sussistano le condizioni sopra rappresentate, dovrà precisare:
- la sussistenza di beni rinunciati con individuazione analitica degli stessi e dei relativi gravami se sussistenti;
- l’esecuzione della cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento e/o di liquidazione giudiziale sui beni immobili rinunciati;
- l’esecuzione della comunicazione ai creditori sociali, al debitore fallito ed ai soci della società fallita o in liquidazione giudiziale;
- la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese in conformità della disposizione della Legge Fallimentare e del Codice rammentando che la prevalente giurisprudenza della cassazione anche a sezioni unite (Cassazione 4060/2010, n. 4061/2010 e n. 4062/2010), ritiene che la cancellazione della società abbia effetti costitutivi e comporti l’estinzione della società, anche in presenza di rapporti non ancora definiti, siano essi di debito o di credito, che passano ai soci pro quota.
Si ricorda che le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 6070/2013, ha chiarito quale sia la sorte dei rapporti giuridici facenti capo alla società al momento della sua estinzione, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese pervenendo alla conclusione che “Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia all’esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore”.