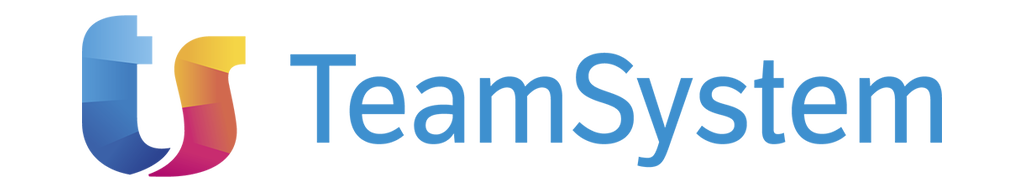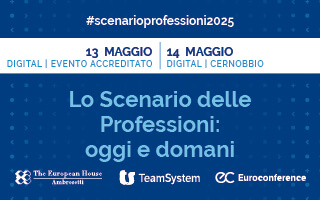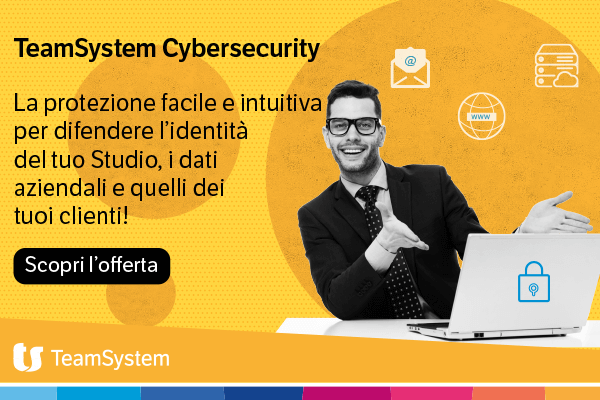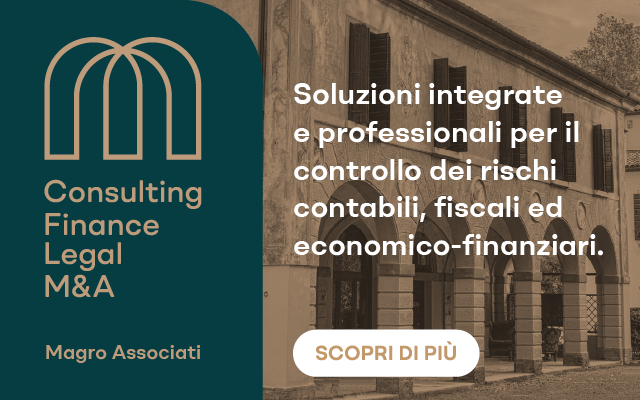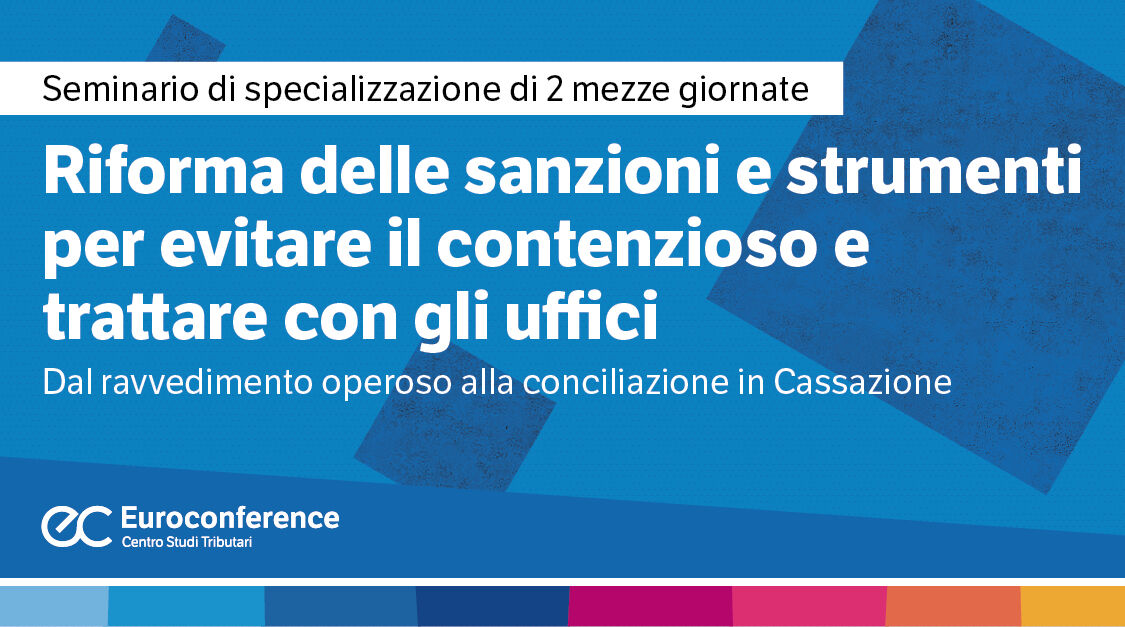Soltanto per inciso, si rammenta che sull’argomento occorre richiamare, altresì, l’articolo 654, c.p.p., il quale disciplina i medesimi rapporti fra processo penale e processo tributario, ma attribuisce rilevanza nel processo tributario anche alla sentenza penale irrevocabile di condanna, richiedendo, altresì, che i fatti materiali oggetto di valutazione devono aver rappresentato “l’oggetto del giudizio penale” e devono sempre essere stati considerati “rilevanti” al fine della pronuncia penale.
Con riferimento all’efficacia intertemporale della nuova disposizione, è stato già chiarito che: “L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso)” (cfr., Cassazione n. 30814/2024, n. 23570/2024, n. 21584/2024, n. 23609/2024, n. 1021/2025).
In tale contesto, già di per sé foriero di molteplici dubbi applicativi, non può non segnalarsi il recentissimo intervento dell’ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 della Corte di cassazione.
Nello specifico, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha disposto, ai sensi dell’articolo 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle SS.UU. delle questioni concernenti l’ambito di efficacia dell’articolo 21-bis, D.Lgs. 74/2000:
- sia in relazione all’estensione, anche al rapporto impositivo – ovvero alla limitazione alla sola parte sanzionatoria – degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario (emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”);
- sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dall’articolo 530, comma 2, c.p.p..
In relazione al primo aspetto, è d’uopo evidenziare che, in seno alla Corte di Cassazione, a un primo orientamento, secondo il quale l’articolo 21-bis, D.Lgs. 74/2000, riguarderebbe l’imposta, e quindi la decisione del giudice tributario sulla sussistenza del presupposto impositivo (cfr., Cassazione n. 23570/2024, n. 23609/2024, n. 21584/2024, n. 30675/2024, n. 30814/2024 e, da ultime, n. 936/2025 e n. 1021/2025), ha fatto seguito la diversa tesi che, invece, limita il campo applicativo della disposizione citata esclusivamente al trattamento sanzionatorio (cfr., Cassazione n. 3800/2025, Cassazione n. 4916/2025, Cassazione n. 4921/2025, Cassazione n. 4924/2025 e Cassazione n. 4935/2025).
Con riferimento al secondo profilo, allo stesso modo, non vi è convergenza di orientamento in ordine alla rilevanza nel giudizio tributario delle sentenze penali di assoluzione pronunziate ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p., e cioè della rilevanza nel processo tributario del giudicato penale di assoluzione in ipotesi di prova mancante, insufficiente o carente (cfr., in senso positivo, seppure in forma inespressa, Cassazione n. 23570/2024 e n. 23609/2024). Il discrimen si fonderebbe sul maggior approfondimento istruttorio che caratterizza il processo penale rispetto a quello civile (e tributario) nonché sulla possibilità, propria del processo penale, di ricostruire la situazione fattuale con estrema certezza.
In definitiva, appare evidente come entrambe le questioni assumano notevole rilevanza per la portata dei principi ad esse sottesi, per cui l’auspicio è che le Sezioni Unite intervengano nel senso di dare compiutezza alle finalità per le quali le citate modifiche sono state introdotte (quindi, confermando che l’ambito di efficacia del giudicato penale risulta esteso al rapporto impositivo; dubbi sussistono, invece, nel caso di contraddittorietà o mancanza della prova).