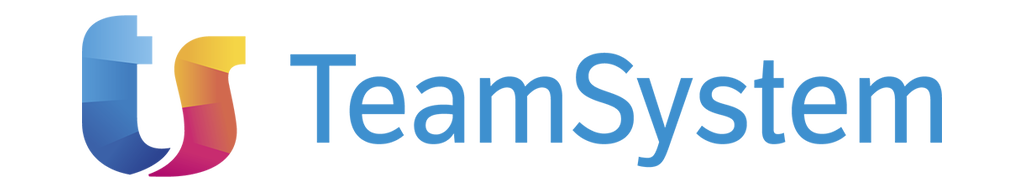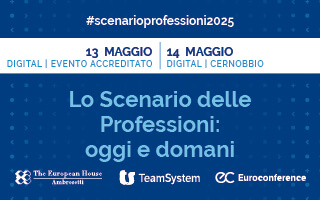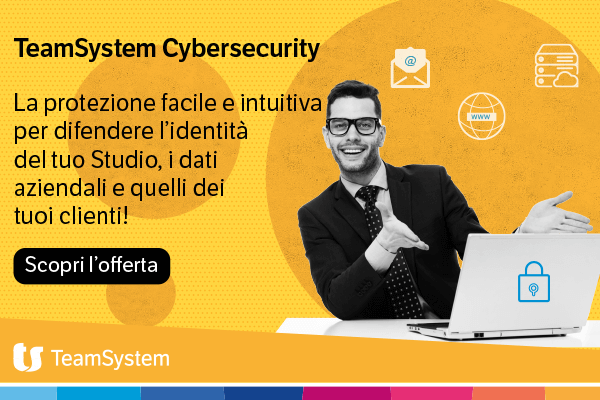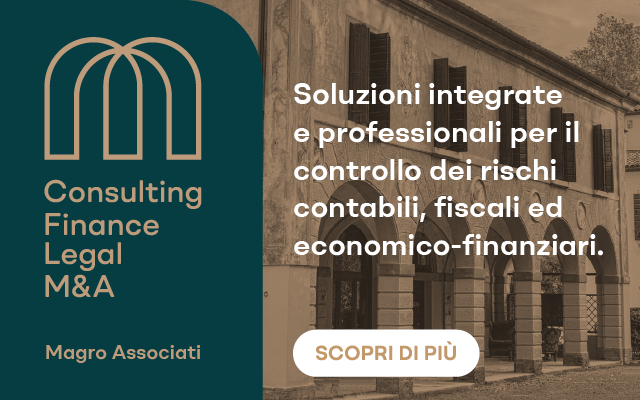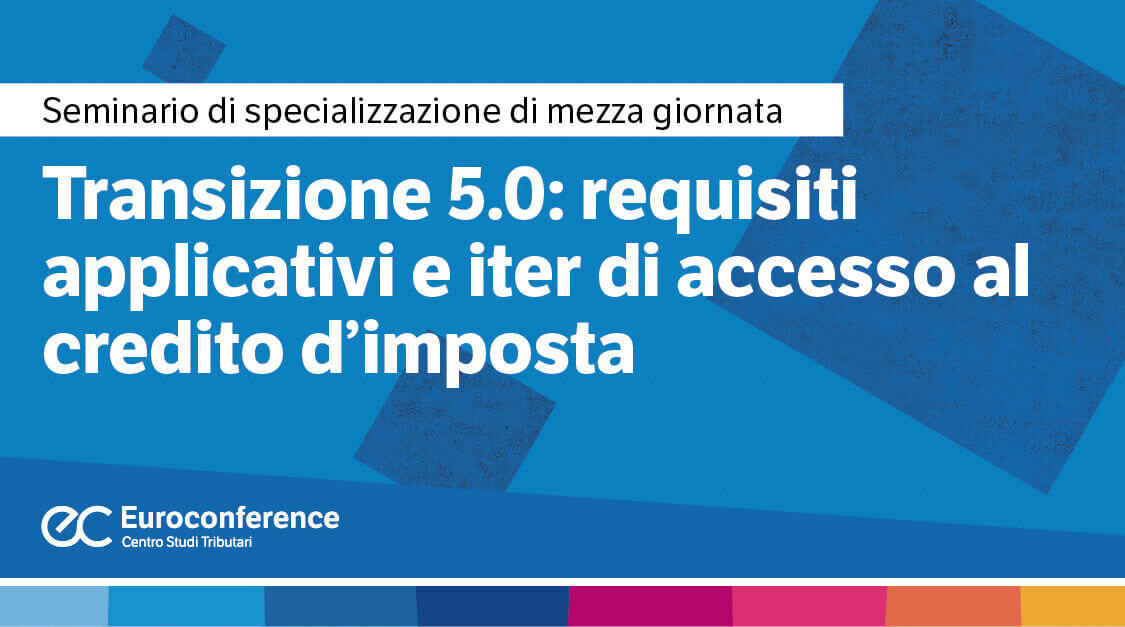Il tema della spettanza della Tremonti ambientale nella misura del cd sovraccosto, vale dire del maggior investimento necessario per realizzare un impianto in grado produrre energia rinnovabile (quindi “verde”, quindi meritevole di una norma per definizione mirata agli investimenti green) – rispetto ad un impianto tradizionale (tipicamente termoelettrico) con analoga capacità produttiva – ha generato una vera telenovela (tanto da meritarsi la definizione di “Tremonti ora per allora”) che sembrava definitivamente risolta da interrogazioni parlamentari, onerosi condoni normativamente previsti per i casi di non applicabilità, risoluzioni della stessa Agenzia delle entrate su come beneficarne per l’appunto “ora per allora”, con una serie di vincoli correlati alla tariffa incentivante, alle dimensioni (vincolo delle PMI) ai limiti di cumulabilità con la tariffa medesima.
Tra le tante eccezioni, precisazioni, limiti, era rimasto lungamente in sordina il tema della spettanza dell’agevolazione nonostante l’investimento in se e per sé non avesse affatto caratteristiche di risparmio energetico, dovendo con tutta evidenza la sua “meritevolezza ambientale” essere piuttosto ascritta alla produzione di energia con un impatto ambientale inferiore alla alternative tradizionali (con riferimento alle quali infatti andava parametrato il beneficio da applicare con il sopra brevemente descritto approccio incrementale), profilo che potremmo definire oggettivo/soggettivo (data la natura di SPV delle società in questione, che rende il profilo, astrattamente oggettivo, in pratica soggettivo essendo unico e inequivoco l’oggetto delle SPV).
Peraltro, il tema era già stato “archiviato” da un paio di sentenze della Cassazione (sentenza n. 30225/2022 e sentenza n. 38043/2022, a tacere delle decine di sentenze sempre della Suprema Corte che si sono focalizzate su altri aspetti, prevalentemente procedurali, apparentemente dando per scontata la spettanza sotto il predetto profilo oggettivo/soggettivo) in replica ad una scomposta ordinanza n. 29365/2020 e i principi di equità (avendone definitivamente beneficiato migliaia di SPV inequivocabilmente accomunate dall’attività svolta) e di certezza del diritto, legittimava la speranza che si trattasse di una questione chiusa. E invece dal 2023 si è sviluppato un filone di sentenze della Corte di segno opposto identicamente arroccate sull’assioma che il presupposto (testualmente immobilizzazioni “necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente”) risulterebbe integrato solo dalle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente dall’esercizio dell’attività svolta dalla stessa impresa che ha effettuato l’acquisto, nell’asserito implicito presupposto (ispirato ad un rigore ambientalista, ad avviso di chi scrive, meritevole di miglior causa) dell’inerenza del danno all’attività dell’impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi.
In realtà, è la stessa norma che richiede che gli investimenti ambientali siano calcolati con l’approccio incrementale ed è proprio tale approccio che qualifica come investimento ambientale il maggior costo che si determina per effetto diretto della scelta ambientalistica (il ricorso a fonti rinnovabili) invece che a fonti tradizionali (tipicamente il termoelettrico) per ridurre, in primo luogo e direttamente, i danni causati all’ambiente dall’esercizio della propria attività di impresa (consistente fuor di discussione nella produzione di energia elettrica) e in via mediata ulteriormente contribuire alla tutela ambientale, consentendo anche a coloro che acquisteranno tale energia (imprese o consumatori) di minimizzare il proprio footprint ambientale. E’ quindi quanto meno fantasioso che l’impianto fotovoltaico non possa beneficiare della detassazione ambientale, perché non idoneo ad incidere sui danni causati all’ambiente dall’esercizio dell’attività svolta dalla stessa impresa che ha effettuato l’acquisto, perché al contrario è esattamente ciò che l’impianto realizza evitando il danno ambientale che deriverebbe dal produrre la stessa energia (ad un costo inferiore per l’impresa, ragion d’essere e parametro dell’incentivo in questione) attraverso fonti tradizionali.
Peraltro, come già accennato, la prima a riconoscere la natura “ambientale” dell’investimento che si sostanzia nell’impiego di energie rinnovabili già nel lontano 2002 fu la stessa Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 226/E/2002 facendo esplicito riferimento alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 3.2.2001 (2001/C 37/03 pubblicata in GUCE 3.2.2001) successivamente modificata dalla disciplina del 1.4.2008 (2008/C 82/01 pubblicata in GUCE 1.4.2008 2008/C82-01) che al § 70, cap. 2.2. Definizioni afferma che la tutela ambientale è costituita da qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di tale danno, o a promuovere l’utilizzazione razionale di tali risorse, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili.
Ma quel che più rileva è la stessa legislazione successiva che conferma l’idoneità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da immettere in rete ad integrare il presupposto della detassazione ambientale (sopra citato). Basta pensare al sopra menzionato tema della cumulabilità della detassazione ambientale in questione e le tariffe incentivanti (dalla II alla V) specificamente previste per le imprese che realizzano impianti fotovoltaici se e nella misura in cui l’energia prodotto è immessa in rete e non auto-consumata. Se avesse pregio la tesi dell’inapplicabilità della detassazione ambientale, la diatriba non avrebbe avuto ragion d’essere e i provvedimenti di legge – da ultimo l’articolo 36, L. 124/2019 che ha disciplinato la possibilità di rinunciare a benefici della detassazione ambientale nei casi di incompatibilità con la Tariffa incentivante. Se il legislatore avesse dubitato della spettanza dell’agevolazione per le imprese in questione non avrebbe previsto una facoltà di scelta se rinunciarvi o meno in base ad un libero calcolo di convenienza.
Al contrario, implicitamente la normativa del 2019 conferma che per le imprese che beneficiano del II conto energia le due agevolazioni, entro certi limiti (segnatamente il 20% del costo dell’investimento) possono coesistere e non vi è interpretazione più autorevole di quella che il legislatore stesso dà.
Peraltro, tale disposizione di legge si lega all’articolo 19, D.M. 5.7.2012, che espressamente aveva riconosciuto la cumulabilità, seppur entro il predetto limite di importo del 20%, della tariffa incentivante (V conto) con la detassazione ambientale di cui alla L.388/2000. Fecero seguito interrogazioni parlamentari (Interrogazione 5/06655 seduta numero 502 del 14.10.2015) e istruzioni del Ministero dello Sviluppo economico (n. 0024327del 12/12/2012 e Nota informativa del 15/6/2015) che si focalizzarono sulla modalità applicativa, mai denotando il minimo dubbio sulla legittima spettanza.
Per completezza anche l’articolo 26, comma 3, D.L. 28/2011, ha riconosciuto la natura di investimento ambientale (seppur nel contesto di altra fonte rinnovabile) della realizzazione di un impianto allo scopo specifico di produrre energia elettrica da immettere in rete (riconoscendo in particolare la cumulabilità con i cd “certificati verdi”
Quello che lascia veramente sconcertati è che di tutto ciò le sentenze che affermano che l’agevolazione spetta sono in caso di autoconsumo non sembrano minimamente essere a conoscenza. Nulla di tutto ciò viene preso in considerazione: si parte dall’idea (come detto quanto meno singolare) che il danno all’ambiente lo fa chi utilizza l’energia (ovviamente non avendo necessariamente contezza concreta di come sia stata prodotta) e non chi produce energia con combustibili fossili e tanto basta per poi finire nei meandri degli aiuti di Stato, su cui non vale la pena entrare, non essendo personalmente disposto a comprare il biglietto di ingresso che dà accesso a tali meandri, preferendo confidare nelle Sezioni Unite.