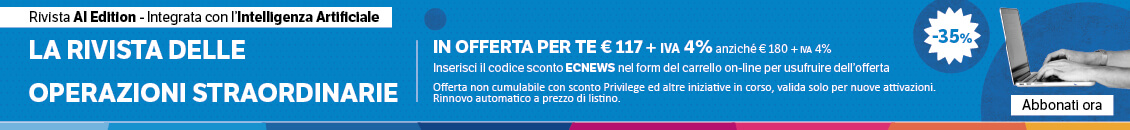L’infondatezza della tesi del c.d. “incasso giuridico” secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione
di Domenico SantoroGianluca CristoforiCon il presente breve contributo si ripercorrono le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16595/2023, in merito all’infondatezza della tesi del c.d. “incasso giuridico”, alla luce di quanto previsto dall’articolo 88, comma 4-bis, Tuir, a seguito delle modifiche recate dal D.Lgs. 147/2015, con la conseguenza che la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al proprio credito sorto per compensi o prestazioni tassabili (se del caso, anche alla fonte) “per cassa”, cui simmetricamente corrispondesse un debito della società iscritto a fronte di un onere dedotto, invece, “per competenza”, non comporterebbe l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare in capo al socio, avendo le nuove disposizioni rimediato al “salto d’imposta” che si sarebbe potuto originare in vigenza del precedente impianto normativo.
Premessa
La controversia da cui trae origine la pronuncia giurisprudenziale in commento afferisce l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore Ires versata, per il periodo d’imposta 2017, da parte di una società di capitali, la quale, in via prudenziale, adeguandosi ai chiarimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria sulla tesi del c.d. “incasso giuridico”, aveva applicato, sugli interessi che avrebbe dovuto corrispondere – in assenza di rinuncia – al proprio finanziatore/creditore, la ritenuta del 26% prevista dall’articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973, nonostante il mancato pagamento degli stessi.
L’istanza di rimborso era stata presentata, nel caso di specie, proprio sul presupposto della non debenza dell’anzidetta ritenuta del 26% dell’ammontare del credito oggetto di rinuncia, tenuto conto che la stessa avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto all’atto della corresponsione degli interessi, tuttavia mai avvenuta nel caso di specie, avendo il creditore rinunciato alla relativa percezione.
Prima di scendere nel dettaglio dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16595/2023, nonché delle criticità che, comunque, permangono, nonostante l’apprezzabile sforzo esegetico, merita ripercorrere l’evoluzione normativa e interpretativa da cui trae origine la tesi del c.d. “incasso giuridico”, dando evidenza delle interpretazioni espresse sul tema nella prassi amministrativa, da taluni autorevoli commentatori e dai principali orientamenti giurisprudenziali.
L’evoluzione normativa e interpretativa da cui trae origine la tesi del c.d. “incasso giuridico”
Com’è noto, con l’ormai risalente circolare n. 73/1994, il Mef esplicitò gli effetti fiscali della tesi del c.d. “incasso giuridico”, precisando che “…la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta”.
Tale tesi interpretativa trova origine in un contesto normativo in cui la rinuncia ai crediti da parte dei soci era considerata irrilevante, ai fini delle imposte sui redditi, per la società debitrice dagli stessi partecipata, determinandosi in capo ai soci un corrispondente incremento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta. Ciò, a prescindere dalla natura del credito del socio e, quindi, anche ove vi corrispondesse, simmetricamente, un debito della società iscritto a fronte di un onere dedotto “per competenza”.
Secondo la tesi del c.d. “incasso giuridico” si equipara, quindi, la rinuncia al credito al suo “incasso virtuale” e a un successivo riversamento alla società – ad altro titolo – della somma virtualmente “incassata”, nonostante detto incasso non sia, in realtà, mai effettivamente avvenuto. La ratio di tale interpretazione risiederebbe nell’esigenza di prevenire possibili “salti d’imposta” derivanti dall’asimmetria impositiva tra quanto accade in capo alla società, che deduce il costo nel periodo d’imposta di competenza, e ciò che accade, invece, in capo al socio, il quale assoggetta a imposizione il provento solo in ipotesi d’incasso. Detto in altri termini, tale tesi interpretativa trova la propria ragion d’essere nell’esigenza di evitare un “salto d’imposta”, rappresentato dalla previa deduzione in capo alla società degli oneri iscritti a fronte dei debiti poi rimessi dai soci e dalla successiva mancata imposizione, espressamente prevista a norma dell’allora vigente articolo 88, Tuir (e, in precedenza, dall’articolo 55, Tuir), della sopravvenienza attiva conseguente alla rinuncia.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha avallato la tesi accertativa dell’Agenzia delle entrate fondata sulla tesi del c.d. “incasso giuridico”. A mero titolo esemplificativo:
- in una controversia avente per oggetto la rinuncia al credito originato dai compensi per royalties vantato dal socio di una società di capitali, la Suprema Corte ha precisato che la stessa “…ne presuppone logicamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale”. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce “…una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali”. Ne deriva che “…la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato”, con la conseguente “…tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta ex articolo 25 D.P.R. 600/73”;
- in una controversia avente per oggetto la rinuncia eseguita dal socio amministratore al credito da questi vantato per il trattamento di fine mandato, la Suprema Corte ha ritenuto che, “…in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 55 (oggi articolo 88), quarto comma, del Tuir che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi articoli 61, quinto comma (oggi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (oggi 101, settimo comma), non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta”;
- in una controversia avente per oggetto la rinuncia eseguita dai soci al credito per gli interessi maturati a fronte di un finanziamento in precedenza concesso a beneficio della società, la Suprema Corte ha precisato che “…appare corretto ritenere che la rinuncia del credito per interessi oggetto di causa da parte dei soci sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. In altri termini, la rinuncia presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia. Altrimenti operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito”.
Nel contesto normativo cui si riferiscono le sentenze citate, volto ad agevolare la patrimonializzazione delle società, le citate pronunce giurisprudenziali fungevano, presumibilmente, da “argine” a un possibile “salto d’imposta”, determinato dalla non tassabilità – in capo alla società – di una sopravvenienza attiva, peraltro accompagnato da un contestuale aumento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio. In questi casi, il presupposto della ricostruzione esegetica operata dai giudici è costituito dalla scelta dei soci di rinunciare alle proprie posizioni creditorie (correlate a passività già dedotte “per competenza” dalla società) in funzione della cointeressenza alle vicende della società partecipata. La rinuncia al credito da parte di un socio costituirebbe, infatti, in tale contesto, espressione della volontà di patrimonializzare la società, non sostanziandosi in una mera remissione del debito, quanto piuttosto in una forma di ristoro direttamente o indirettamente ricollegato a una controprestazione.
A fronte di tale tesi interpretativa, si riscontrano, tuttavia, taluni orientamenti delle CGT favorevoli al contribuente. A mero titolo esemplificativo:
- con la sentenza n. 354/2018, la CTR della Lombardia (attuale CGT di II grado della Lombardia) ha ritenuto che, “Presupposto ineludibile per l’imposizione di tali somme (redditi di capitale, ndA) è il loro conseguimento, ossia l’incasso “reale” che determini un effettivo incremento patrimoniale per il soggetto che le percepisce. …Nel caso di specie, dunque, l’incasso appare più “virtuale” e “meramente giuridico”, al punto da rendere del tutto irrazionale la tassazione di un arricchimento mai verificatosi – e che difficilmente si verificherà – in capo all’attuale ricorrente”;
- con la sentenza n. 197/II/2018, la CTP di Reggio Emilia (attuale CGT di I grado di Reggio Emilia) ha precisato che “…l’incasso giuridico non è previsto da alcuna disposizione normativa e si pone in contrasto con i principi generali dell’ordinamento tributario nonché con quelli specifici sulla tassazione dei redditi di capitale che consegue all’effettiva percezione delle somme. L’ambito normativo delineato dal legislatore tributario è infatti piuttosto chiaro: i redditi di capitale sono tassati secondo il principio di cassa”.
Quanto alla dottrina e agli autorevoli commentatori che si sono occupati della controversa questione, basti citare, tra gli innumerevoli contributi, le parole di G. Andreani, il quale ha sostenuto che, “La tesi dell’incasso giuridico non è condivisibile …perché finisce per assoggettare a imposizione un reddito che il creditore non ha materialmente percepito, così equiparando qualsiasi atto di disposizione di un credito al suo incasso. Invece, l’articolo 1236 cod. civ. colloca la remissione del debito tra i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, rappresentando un modo in cui il creditore può disporre del proprio diritto di credito, senza incassarne l’importo, mentre per i redditi tassati “per cassa” rileva l’effettiva percezione del reddito, non il mero utilizzo del diritto di credito (il quale evidentemente non è ritenuto dal legislatore di per sé sufficiente per far scattare la tassazione in capo al creditore)”.
Il quadro normativo di riferimento è poi mutato per effetto delle modifiche apportate all’articolo 88, Tuir dal D.Lgs. 147/2015; la “nuova” norma, diversamente dalla previgente disciplina, ora dispone che “La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale…”. Nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 147/2015 è stato chiarito che “…viene riformato il regime fiscale Ires delle rinunce dei crediti da parte dei soci, riconducendolo a sostanziale unità, a prescindere dalla modalità con cui l’operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti. In particolare … il nuovo regime qualifica fiscalmente “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. …In altri termini, nei limiti del valore fiscale del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione e il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); l’eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile”.
A seguito del mutato quadro normativo, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 124/E/2017, si è espressa in merito alla rilevanza reddituale, in capo agli amministratori (soci e non soci), della rinuncia al trattamento di fine mandato, precisando che:
- con riferimento alla rinuncia operata dagli amministratori-soci, “…i crediti rinunciati – che si intendono giuridicamente incassati – dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società”;
- con riferimento alla rinuncia operata dagli amministratori non soci, “…non trovando applicazione … il comma 4-bis dell’articolo 88 del Tuir, sarà la società istante ad assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato. Per gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del c.d. incasso giuridico non si applica ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale”.
Sulla medesima questione della pretesa rilevanza reddituale, in capo agli amministratori, della rinuncia al TFM, si è poi espressa, in senso sostanzialmente critico rispetto alla posizione dell’Amministrazione finanziaria, anche l’Aidc, con la norma di comportamento n. 201/2018, a parere della quale “La remissione del trattamento di fine mandato effettuata alla società dall’amministratore è assimilabile alla percezione dell’indennità solo nel caso in cui la corrispondente rinuncia al credito vantato gli attribuisca un vantaggio economico. In assenza di tale vantaggio, la remissione non comporta in capo all’amministratore il realizzo di alcun reddito imponibile”. Ha osservato l’Aidc, più in dettaglio, che, con riguardo ai debiti per TFM, stanziati a fronte di accantonamenti dedotti “per competenza”, “La mera remissione del debito non comporta alcun beneficio per l’amministratore socio e non può, pertanto, essere assunta quale forma di utilizzo o godimento del diritto di credito. La mancata percezione rende l’operazione fiscalmente ininfluente per l’amministratore, ancorché socio, in quanto non gli attribuisce alcun vantaggio economico. Il credito così rinunciato ha un valore fiscale nullo in quanto la fattispecie reddituale sottostante non ha mai concorso a formare la base imponibile del reddito dell’amministratore. Ne consegue che, per l’amministratore, la rinuncia del credito non comporta un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, disciplinato dall’articolo 94, comma 6 del Tuir. Per quanto riguarda la società, che imputa a una posta di patrimonio netto l’ammontare del credito rinunciato dall’amministratore socio, trova applicazione l’articolo 88, comma 4-bis del Tuir, con la determinazione di una sopravvenienza attiva imponibile da assoggettare a imposizione mediante una corrispondente variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi”.
Le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione
Da quanto si apprende dalla lettura della succitata sentenza, con uno dei motivi di ricorso – poi accolto dalla Suprema Corte – il contribuente aveva eccepito la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 26, comma 5, e 26-quater, D.P.R.600/1973, dell’articolo 88, comma 4-bis, Tuir, nonché degli articoli 23 e 53, Costituzione, oltre che dell’articolo 1 del protocollo addizionale Cedu.
A parere del contribuente, infatti, il regime fiscale delle rinunce ai crediti da parte dei soci, a seguito della riforma attuata con il D.Lgs. 147/2015, non sarebbe più compatibile con la tesi dell’incasso giuridico. A parere del contribuente, inoltre, la tesi del c.d. “incasso giuridico” non sarebbe applicabile nel caso in cui il creditore fosse una società non residente (nel caso di specie, una società lussemburghese), non sussistendo il rischio del c.d. “salto di imposta” che detta tesi interpretativa mira invece a scongiurare.
In relazione a tali aspetti, la Corte di Cassazione ha dapprima ribadito che “La natura reddituale o patrimoniale della rinuncia del socio al credito vantato nei confronti della società non è univoca. Infatti, se sotto il profilo formale la rinuncia determina una sopravvenienza, dal punto di vista sostanziale l’effetto coincide con quello che si realizzerebbe ove la società pagasse il suo debito ed il socio apportasse nuovo capitale. La teoria volta a dare rilievo fiscale, in caso di rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società partecipata, al c.d. “incasso giuridico” riflette detta ambiguità e si fonda, pacificamente, su una fictio iuris atteso che la rinuncia, sul piano della tassazione, viene equiparata ad un incasso, pur materialmente inesistente, con conseguente imponibilità dello stesso. Il presupposto da cui muove la teoria dell’incasso giuridico… è che i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione e per la società partecipata non costituiscono sopravvenienze. Ne consegue che detta rinuncia, ove abbia ad oggetto (come nel caso degli interessi su finanziamenti erogati dai soci, ma anche dei compensi spettanti agli amministratori) potenziali redditi soggetti a tassazione per cassa, determina un «salto d’imposta» in quanto il credito è correlato ad un elemento [di] reddito deducibile per il debitore secondo il principio di competenza ed è tassabile per il creditore secondo il principio di cassa. Di qui la necessità, mediante una fictio iuris, di equiparare, ai fini fiscali, la rinuncia all’incasso e di sottoporne l’ammontare a prelievo fiscale, anche mediante ritenuta d’imposta”.
La Suprema Corte, inoltre, ha ribadito che la tesi del c.d. “incasso giuridico” “…si giustifica in un regime fiscale … in cui la rinuncia al credito, sul versante della società debitrice, è soggetta a un regime di non tassabilità. La fictio iuris descritta, infatti, pone rimedio al c.d. “salto di imposta” derivante da un’asimmetria di imposizione, sul versante della società e del socio, che si verificherebbe, in un regime di tal fatta, nel caso in cui alla società fosse concesso di portare in deduzione il costo del finanziamento per competenza e di non subire alcuna tassazione a seguito della rinuncia e correlativamente anche il socio non subisse alcuna tassazione, pur beneficiando dell’incremento di valore fiscale della propria partecipazione. La descritta fictio iuris per rimediare al salto di imposta, trovava la sua ragion d’essere nel testo previgente dell’articolo 55 (ora articolo 88), comma 4, Tuir – prima delle modifiche apportate con il D.Lgs. 147/2015 – che escludeva dalla nozione di sopravvenienze attive, fiscalmente rilevanti, tutte le rinunce dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, sia di natura finanziaria che commerciale, indipendentemente dalla loro proporzionalità”.
A parere della Corte di Cassazione, “Le asimmetrie cui la regola dell’incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state … risolte dal legislatore mutando la disciplina dell’articolo 88 Tuir sul versante della società partecipata e degli articoli 94 e 101 sul versante del socio creditore”. Più in dettaglio, la Suprema Corte ha preso atto che “L’assetto normativo … è mutato in virtù delle modifiche apportate dall’articolo 13 d.lgs. n. 147 del 2015. Con la modifica, il trattamento della rinuncia del socio non trova più collocazione nell’articolo 88, comma 4, Tuir, ma nel successivo comma 4-bis il quale prevede, nel testo applicabile alla fattispecie, che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Inoltre, il nuovo testo impone al socio di comunicare il valore del credito alla partecipata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore assunto è pari a zero, con conseguente tassazione dell’intera rinuncia, fiscalmente qualificata come sopravvenienza attiva. Correlativamente, gli articoli 94, comma 6, e 101, comma 7, Tuir hanno previsto, sul versante del socio, che l’ammontare della rinuncia al credito che si aggiunge al costo della partecipazione è nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia; che la rinuncia non è ammessa in deduzione e che il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione sempre nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito. Il nuovo regime, pertanto, ha posto in correlazione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione. A seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore. Accade, pertanto, che la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione, diversamente da quanto prospettato nel precedente regime sia dalla Agenzia delle entrate che da questa Corte a sostegno della teoria dell’incasso giuridico. Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata”.
In ragione di quanto fin qui rappresentato, la Corte di Cassazione ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi di capitale – in ragione di quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, t.u.i.r. a seguito delle modifiche di cui all’articolo 13 legge 14 settembre 2015, n. 147 – la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’articolo 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all’asimmetria fiscale o “salto d’imposta” di cui al precedente regime”.
Talune residue criticità in ordine alla tesi del c.d. “incasso giuridico”
Nonostante l’apprezzabile sforzo esegetico della Corte di Cassazione residuano, tuttavia, talune criticità in ordine alla tesi del c.d. “incasso giuridico”:
- la sentenza della Corte di Cassazione in commento sancisce l’illegittimità della tesi del c.d. “incasso giuridico” limitatamente ai periodi d’imposta di vigenza del “nuovo” articolo 88, comma 4-bis, Tuir, riaffermando, invece, la validità di detta tesi interpretativa con riguardo ai periodi d’imposta precedenti. In relazione a tale aspetto, si condivide quanto osservato da autorevoli commentatori, a parere dei quali “La finzione dell’incasso e la connessa tassazione di ricchezza inesistente contrastano chiaramente con il principio di capacità contributiva: in sostanza, la teoria dell’incasso giuridico è chiaramente un vulnus nel sistema e tanto emerge chiaramente anche solo ad esaminare la locuzione utilizzata dall’Amministrazione, atteso che l’incasso non può essere giuridico, sostanziandosi in un fatto. La giuridicità dell’incasso stride sia rispetto alla nozione di “possesso” sia rispetto a quella di percezione: il mancato incasso delle somme a titolo d’interessi non fa insorgere in capo al socio rinunciante alcuna materia imponibile a titolo di reddito di capitale, stante l’ineludibile necessità della specifica percezione per la tassazione”;
- la medesima sentenza si esprime in relazione a una fattispecie in cui il credito del socio e il corrispondente debito della società traggono origine da un costo dedotto dalla società “per competenza”. Ove, tuttavia, il credito traesse origine da un costo deducibile “per cassa” è stato condivisibilmente osservato che, “A fronte della originaria “non deduzione” del compenso rilevato a conto economico si ha la successiva imposizione in capo alla società della rinuncia allo stesso, generandosi così nel complesso una base imponibile indebita, maggiore di quella che complessivamente si avrebbe avuto se la società non avesse mai rilevato in contabilità tali compensi amministratore…. L’unica possibile soluzione per evitare che, in applicazione della condivisibile interpretazione della Suprema corte, si generi in capo alla società una base imponibile fittizia, che non corrisponde a un effettivo reddito generatosi, è riconoscere alla società la possibilità di dedurre, nell’esercizio in cui viene rinunciato il corrispondente credito, il costo per il compenso amministratore, fingendo nuovamente (ma con valenza opposta) che tale compenso sia stato pagato (pagamento “giuridico”) e poi riversato alla società. Sarebbe utile un chiarimento in tal senso da parte delle Entrate”. Ove il debito della società traesse origine, invece, da un fatto amministrativo da cui non potrebbe mai derivare un costo deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa (come nel caso dei debiti per dividendi deliberati, ma non ancora distribuiti), la tesi del c.d. “incasso giuridico” non sarebbe invocabile, in quanto non verrebbe in rilievo quell’asimmetria tra regime impositivo della società e regime impositivo del socio e, in ultima analisi, quel “salto d’imposta” che giustificherebbe la tesi dell’Amministrazione finanziaria.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie”.