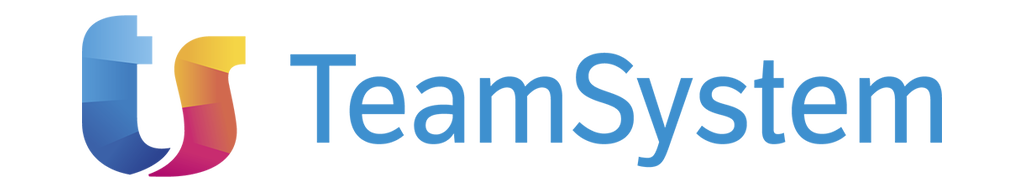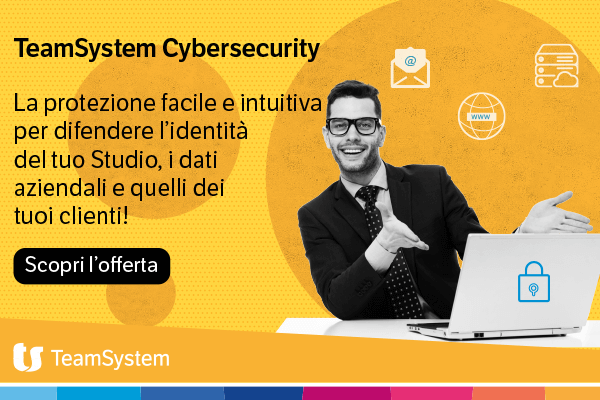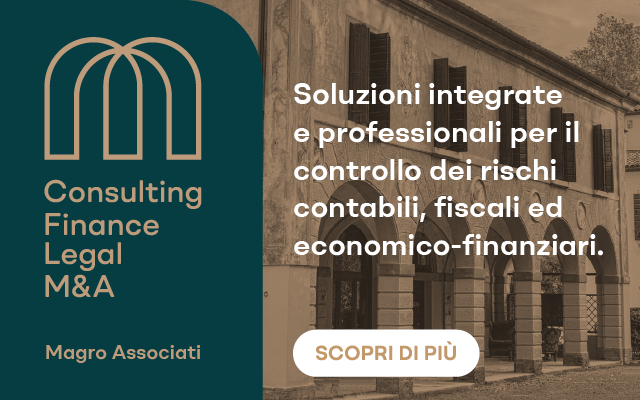Trasferte e trasfertismo: nuove conferme dalla Corte di Cassazione
di Luca VannoniTra i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro rientra la possibilità di destinare il proprio dipendente a svolgere la prestazione di lavoro in un luogo temporaneamente diverso rispetto a quello ordinario, cosi come definito al momento dell’assunzione o nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.
Tale spostamento viene definito come trasferta. In assenza di una norma specifica, la regolamentazione dell’istituto è delineata, nei suoi aspetti sostanziali, dalla giurisprudenza sulla base dei principi generali del rapporto di lavoro previsti dal codice civile, dalla contrattazione collettiva, per quanto attiene il trattamento economico, e dal Tuir, art. 51, co. 5, relativamente al trattamento fiscale (che esplica i suoi effetti anche in materia contributiva, stante l’armonizzazione delle basi imponibili). Quando la trasferta è abituale e strutturalmente connessa alla prestazione di lavoro si entra nel concetto di trasfertismo: in questo caso, il lavoratore non ha una sede di lavoro fissa e predeterminata, in quanto è obbligato a continui spostamenti all’interno dell’area di lavoro individuata contrattualmente. Rispetto alla trasferta, al trasfertista si applica, per quanto riguarda la disciplina fiscale, il co. 6 dell’art. 51 del Tuir, disciplina che prevede una parziale imponibilità delle indennità da trasfertista (50%).